Dagli anni ’80 del secolo scorso a oggi sono stati elaborati numerosi
strumenti concettuali per mettere in evidenza il crescente impatto esercitato
dalle attività o impronte umane sul pianeta Terra. Questi strumenti sono stati
associati a misure quantitative di grandezze fisiche (superficie di un
territorio, massa di una sostanza, volume di un gas, ecc.), in modo da renderne
più comprensibile il significato.
Alcuni di questi strumenti concettuali hanno avuto larga diffusione, per la
loro chiarezza e adattabilità a varie situazioni. Per esempio, il concetto di
impronta ecologica, introdotto nel 1996, viene adesso ampiamente utilizzato sia
nelle scuole, sia nelle pubbliche amministrazioni.
Il 22 gennaio 2021 è entrato in vigore il Trattato ONU per la Proibizione
delle Armi nucleari (Treaty of Prohibiting Nuclear Weapons – TPNW), che decreta
l’illegalità delle armi nucleari: questa decisione storica – anche se di non
immediata attuazione – può aiutarci a riflettere su altro strumento concettuale
che potrebbe essere molto utile proporre: l’impatto della crescente presenza di
sostanze radioattive sul nostro pianeta, che sta rendendo il nostro pianeta
sempre meno confortevole per tutti i suoi abitanti: quelli presenti, e quelli
che vivranno nei prossimi secoli.
L’IMPRONTA ECOLOGICA
L’idea di misurare in modo quantitativo ma intuitivo le ‘tracce’ che
le società umane – dai singoli individui alle Nazioni, fino alla comunità
globale – lasciano sul nostro pianeta, i due Autori canadesi Mathis Wackernagel e William Rees hanno introdotto nel 1996 il concetto di ‘Impronta ecologica’ nel loro libro Our
Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth.
L’impronta ecologica misura l’area biologicamente produttiva di mare e di
terra necessaria a rigenerare le risorse consumate da una popolazione umana e
ad assorbire i rifiuti prodotti.
Nel 1961 l’umanità usava
il 70% della capacità globale della biosfera, ma nel 1999 era arrivata al
120%. Poi, dall’inizio degli anni 2000, stiamo consumando sempre più velocemente
le risorse e i servizi che la natura ci offre: stiamo intaccando il ‘capitale
naturale’ contraendo dei debiti che renderanno sempre più difficile la vita
alle generazioni future.
Attualmente l’umanità – nel suo insieme – sta consumando l’equivalente di
1,6 Terre: da un lato preleviamo troppe risorse rispetto ai tempi necessari
alla natura per riprodurle; dall’altra produciamo troppi rifiuti, che si
accumulano sul suolo, negli oceani, nell’atmosfera.
Nel 2020 alcuni studiosi hanno fornito una nuova informazione per
documentare il dilagante impatto umano sul pianeta, pubblicando sulla
rivista Nature i risultati di
una lunga e complessa serie di misure da cui risulta che la massa globale di
‘cose’ prodotte dall’umanità ha superato la biomassa di tutti i viventi.
Si tratta di materiale edile, plastiche, metalli… insomma, tutto ciò che viene
prelevato dalle componenti geologiche e biologiche della natura, e trasformato
in infrastrutture e oggetti ‘inanimati’.
2
Questa quantificazione dell’impresa umana offre una caratterizzazione
quantitativa, ma anche simbolica, secondo gli Autori dello studio, dell’epoca
in cui viviamo: l’Antropocene.
L’era radioattiva
Antropocene è un termine introdotto ufficialmente dalla comunità
scientifica il 29 agosto 2016 quando – dopo numerose riunioni e discussioni –
il Working Group on the Anthropocene, istituito dalla Commissione
Internazionale sulla Stratigrafia, comunicò che l’impatto umano sul pianeta è
diventato così esteso e profondo, che richiede di individuare il periodo
geologico in cui viviamo come una nuova era: l’Antropocene [1].
Gli studiosi hanno preso in esame vari eventi che potessero funzionare come
‘marcatori’ dell’inizio di questa nuova epoca, tra cui l’aumento esponenziale
del consumo di risorse (segnalato dall’impronta ecologica), oppure l’aumento
della concentrazione di CO2 in atmosfera (conseguente alle
attività produttive alimentate dai combustibili fossili). Il nuovo traguardo
prima citato (la produzione di cose artificiali che supera la massa complessiva
dei viventi) non era ancora stato raggiunto. La scelta finale degli scienziati
è caduta sugli elementi radioattivi prodotti dalle esplosioni di ordigni
nucleari, a partire dal primo test nucleare, il 16 luglio 1945 ad Alamogordo,
nel Nuovo Messico. Negli anni successivi, dopo i tragici bombardamenti di
Hiroshima e Nagasaki, fino al 1998 furono compiuti test nucleari (con una media
di una esplosione ogni 9,6 giorni!) che lasciarono tracce facilmente rilevabili
in atmosfera, negli organismi viventi, nelle acque oceaniche.
Barry
Commoner (1917-2012), biologo e pacifista statunitense, era già un attivista negli anni della guerra
fredda, nel periodo in cui furono più intense e frequenti le esplosioni di
bombe nucleari nell’atmosfera, con una intensa ricaduta, su tutto il pianeta,
dei prodotti radioattivi di fissione degli esplosivi nucleari. Nel
1958 Commoner costituì insieme ad altri un comitato di protesta contro le bombe
atomiche e iniziò la pubblicazione di un notiziario, «Nuclear
information», divenuto, nel 1964, «Scientist and Citizen», e trasformato, nel
1969, nella rivista mensile «Environment».
La
biologa Rachel Carson (1907-1964) è nota soprattutto per il
suo libro ‘Primavera silenziosa’, in cui denunciò con forza i rischi legati all’uso
indiscriminato di alcune sostanze chimiche usate come insetticidi (come il
DDT). Collaborò anche con Commoner e altri studiosi nel denunciare il
pericolo delle emissioni radioattive. Nel 1964 tenne un discorso a un
convegno di 1500 medici in California, in cui spiegò dettagliatamente come i
radionuclidi derivanti da depositi di scorie nucleari o da tests svolti in
atmosfera si spostavano lungo le catene alimentari e venivano dispersi fino a
luoghi remoti come l’Artico, dove danneggiavano i bambini allattati al seno
dalle loro mamme Esquimesi.
Radioattività “pacifica” e
“sostenibile”?
Come ho ricordato in un articolo di alcuni giorni fa, il 1º luglio 1968 fu sottoscritto
da USA, Regno Unito e Unione Sovietica un Trattato di
Non Proliferazione degli Armamenti Nucleari (Treaty on the Nonproliferation of Nuclear Weapons (NPT) che
entrò in vigore il 5 marzo 1970. Francia e Cina vi aderirono
nel 1992. L’articolo IV
del Trattato assicurava tuttavia a ciascuno degli Stati membri il diritto a usi
pacifici della tecnologia nucleare: “…tutti gli Stati membri hanno il
diritto inalienabile a sviluppare ricerca, produzione e uso dell’energia
nucleare per scopi pacifici, senza discriminazioni. […].
Era il periodo in cui si pensava che l’energia atomica avrebbe portato
benessere a tutta l’umanità, fornendo una forma di energia economica,
ambientalmente pulita, e sicura. Si sottolineò con enfasi l’importanza della
cooperazione internazionale per sviluppare nuove applicazioni dell’energia
nucleare, specialmente nei aree in cui erano presenti Stati che non
possiedono armi nucleari,con la dovuta considerazione per le esigenze delle
aree in via di sviluppo del mondo.
Nonostante la complessità della filiera, gli enormi investimenti
finanziari, i vincoli di sicurezza richiesti per la costruzione di una centrale
nucleare, il moltiplicarsi di incidenti e le segnalazioni dei rischi
associati all’eventuale uso bellico, la produzione di energia da fonte
nucleare si è diffusa in molte parti del mondo. Come segnala lo studioso
Stephen Herzog in un recente articolo, L’Agenzia
Internazionale per l’Energia atomica(International Atomic Energy Agency – IAEA)
presenta una lista di 220 reattori attualmente impiegati per la ricerca
nucleare in 53 Stati, e 440 reattori per la produzione di energia, presenti in
30 Paesi.
Dalle miniere alle scorie – una tragica
eredità per le prossime generazioni
Immaginando di guardare il nostro pianeta da ‘fuori’ e misurare le fonti di
radioattività che dalla Terra emettono verso lo spazio, scopriamo che in
numerose aree del mondo sono presenti luoghi di emissioni radioattive – alcuni
noti, altri segreti o sconosciuti – che contribuiscono a caratterizzare questo
periodo geologico come ‘radioattivo’. Al materiale radioattivo legato
alla filiera di produzione militare occorre aggiungere quello che riguarda la
costruzione di centrali per la produzione di elettricità: molte di esse sono ormai
arrivate a fine vita, e dovrebbero essere dismesse. Questo crea un grave
problema del ‘decommissioning’: non basta infatti smantellare gli impianti, ma
occorre provvedere alla decontaminazione finale di tutti i materiali
radioattivi.
Se dalla nostra postazione ‘fuori’ dal pianeta volessimo avvicinarci, in
molti luoghi scopriremmo altri indizi della presenza di radiazioni: sono i
segni delle conseguenze drammatiche che la radioattività ha lasciato sulle
popolazioni umane e negli ambienti naturali.
Conseguenze di test nucleari
In un articolo pubblicato pochi mesi fa da due studiosi francesi, Jean
Marie Collin e Patrice Bouveret, per conto della Heinrich Böll Foundation e di
ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons France), ricordano che
le conseguenze delle esplosioni atomiche sperimentali sono ancora presenti oggi
in molte parti del mondo, e costituiscono ancora un importante rischio per la
salute umana e degli ecosistemi.
Tra gli esempi che citano vi è il caso della Francia, che tra il 1960 e il
1996 eseguì 17 test nucleari in Algeria e 193 nella Polinesia francese. In
Algeria, in particolare, la Francia decise di ‘seppellire’ tutti i materiali
contaminati nel deserto; ancor oggi non è noto dove e quanto materiale
radioattivo vi è stato sepolto. La situazione della Francia non è unica:
attualmente sono numerosi i luoghi in cui le aree in cui sono stati eseguiti
test nucleari da vari stati sono state malamente o per nulla decontaminate, e
non si è mai provveduto a registrare i danni umani, né tantomeno a risarcire le
vittime.
Miniere di uranio e danni alla salute
La pericolosità del lavoro nelle miniere di uranio era ben nota fin dai
tempi della 2° guerra mondiale: dal 1944 al 1986 quasi 30 milioni di tonnellate
di minerali di uranio sono stati estratti in territori della Nazione
Navajo. Molte comunità di indiani Navajo lavorarono in queste miniere, e
spesso le loro famiglie abitavano in stretta vicinanza con le aree di scavo.
Attualmente le miniere sono state chiuse, ma è rimasta una eredità contaminata:
più di 500 miniere abbandonate sono ancora radioattive, così come molte
abitazioni e fonti d’acqua.
La miniera di Jaduguda, nello stato del Bihar, in India, ha iniziato le
operazioni nel 1967. E’ la prima e più importante delle miniere di uranio di
questo Paese. Più di 35.000 persone vivono in vicinanza di questo complesso di
scavi e operazioni minerarie, e per molti anni hanno denunciato gli effetti
devastanti sulla salute delle persone; numerose sono le testimonianze di deformità congenite,
infertilità, problemi respiratori, aborti nei villaggi vicini agli scavi.
Tra le aree in cui in Australia sono stati identificati depositi di uranio,
e avviati lavori di scavo per l’estrazione del minerale che lo contiene, molte
sono situate in zone che le popolazioni locali considerano sacre. Ciò non
ha impedito alle imprese interessate di avviare le estrazioni, approfittando del
fatto che la maggior parte delle comunità indigene non ha diritti di proprietà
sulle terre abitate da millenni.
Stati Uniti, India, Australia… sono solo alcuni esempi tra i tantissimi che
da decenni denunciano la presenza di gravi problemi sanitari e di danni
ambientali nelle aree (molte delle quali in territori abitati da popolazioni
indigene) in cui ‘nasce’ la filiera dell’uranio.
Uranio impoverito e poligoni di tiro
Lungo la filiera che porta alla costruzione di centrali nucleari e di
materiale bellico viene prodotto un materiale di scarto che contiene varie
miscele di isotopi dell’uranio: l’uranio ‘impoverito’ (depleted uranium – DU):
essendo un materiale di elevata densità, è stato impiegato sia per uso civile
(contrappesi stabilizzatori di aerei) sia per uso militare, per la costruzione
di proiettili ad altissimo potere penetrante.
La tragedia
dell’uranio ‘impoverito’ inizia molti anni fa. Nel 1978 il Pentagono annuncia
la produzione di proiettili con uranio impoverito; da allora questi
proiettili sono stati utilizzati in moltissimi campi di battaglia (dall’Irak
all’Afganisthan, fino ai Balcani) creando crescente allarme per gli i numerosi
e devastanti effetti tardivi, a lungo termine, provocati dall’uso di queste
particolari munizioni.
Molti soldati che hanno partecipato ad azioni di guerra utilizzando quei
tipi di proiettili hanno manifestato nei mesi e anni successivi gravi
patologie, riconducibili alle nanoparticelle generate dalle esplosioni a
grandissime temperature dei metalli pesanti presenti nelle munizioni con DU.
Numerosi luoghi in cui sono stati usati proiettili di questo tipo sono tuttora
fonti di prodotti tossici che continuano a danneggiare l’ambiente e la salute
dei residenti. Anche in zone di pace si sono manifestate patologie
collegate all’uso di uranio impoverito. Per esempio in Sardegna, nei poligoni
di tiro, cioè nelle aree occupate dall’esercito e dagli alleati NATO per
sperimentare nuove forme di armi.
Quali discariche per le scorie
radioattive?
Più di un quarto di milione di tonnellate di rifiuti altamente radioattivi
si trova immagazzinato nei pressi delle centrali nucleari e dei luoghi di
produzione di materiale bellico: 90.000 tonnellate solo negli Stati Uniti.
Questi rifiuti, che continuano a emettere radiazioni e danneggiano la salute
umana e l’ambiente, sono da anni – molti da decenni – in attesa di essere
trasferiti in modo permanente in depositi geologici: ma nessuno finora è pronto
ad accoglierli. In questa attesa, i serbatoi di contenimento – acciaio, vetro,
altri materiali – sono soggetti a naturale corrosione e degrado, che si sta già
manifestando.
Come accennato altrove, la ricerca di luoghi adatti a
conservare, lontano dagli umani e dagli ecosistemi, i rifiuti prodotti lungo
tutte le tappe delle filiere dell’uranio è ancora irrisolta: per anni ogni
luogo che sembrava adatto si è rivelato inadeguato, e solo da qualche anno si
intravede qualche soluzione. L’orientamento attuale è quello di scavare
dei buchi profondissimi, raggiungendo zone in cui gli scambi con il mondo
esterno siano ridotti al minimo, e stivare lì – in enormi depositi – il
‘pattume’ più pericoloso, quello che continuerà a emettere radiazioni per
decine di migliaia di anni. Due siti sono in fase avanzata di costruzione, uno
in Finlandia e l’altro in USA: raggiungeranno profondità di 500 – 600 metri, e
da qui si accederà a enormi ‘stanze’ in cui verranno accumulati questi rifiuti
‘speciali’. Un grande recinto di terra battuta circoscriverà
l’imboccatura superficiale della struttura di smaltimento sotterranea.
Ma come avvisare le future generazioni che forse popoleranno la Terra tra
decine di migliaia di anni, facendo capire che non dovranno assolutamente
entrare all’interno di quei siti? Queste persone non parleranno le lingue che
usiamo adesso, avranno altri simboli, altri modi di comunicare. Per il sito
americano (Waste Isolation Pilot Plant – WIPP) una delle proposte è
illustrata qui: Spike Field, in cui
minacciose punte di pietra posizionate in modo caotico si slanciano verso
l’alto. Una penosa testimonianza della stupidità umana del XXI secolo…
Un traguardo collaterale importante – nel diffondere la notizia
dell’approvazione del Trattato ONU, che dichiara illegali le armi atomiche –
può essere anche quello di ridurre il tragico lascito radioattivo alle
generazioni future, sottolineando l’insostenibilità di tutte le filiere
nucleari.
NOTA. Non ho affrontato il tema delle applicazioni della radioattività a
settori diversi dalla produzione di energia e dalla costruzione di armamenti.
Un articolo divulgativo pubblicato da Enrico Mainardi (Ansaldo
Energia) passa in rassegna numerose altre applicazioni che implicano l’uso
diretto o indiretto dell’energia nucleare e della radioattività. I più
significativi campi di applicazione riguardano l’industria, il settore
alimentare e ambientale, la geologia e l’archeologia, la medicina, ecc.
In campo medico in particolare sono in pieno sviluppo nuove
applicazioni, sia ad uso diagnostico che terapeutico.
Sarebbe interessante e utile capire in che misura questo specifico uso
della radioattività incide nella produzione globale di emissioni radioattive, e
come sia possibile orientare questo campo di ricerca e di applicazione in modo
da minimizzarne l’impatto lungo tutta la filiera.
[1] Nuclear Waste in the Anthropocene. Uncertainties and
Unforeseeable Timescales in the Disposal of Nuclear Waste | GAIA 26/2
(2017): 96–99 |
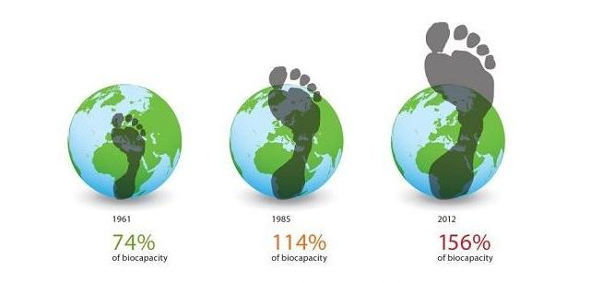

Nessun commento:
Posta un commento